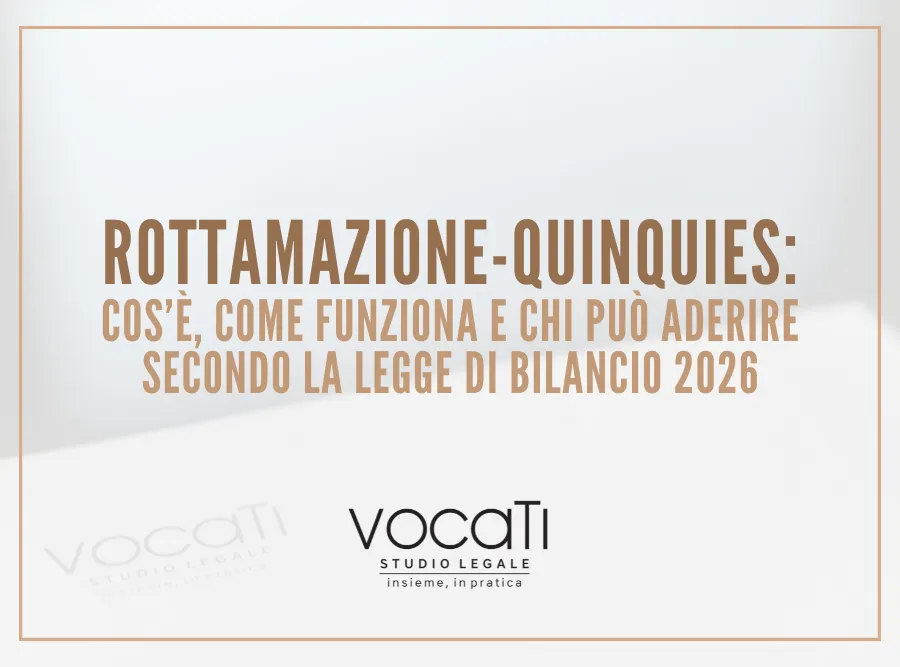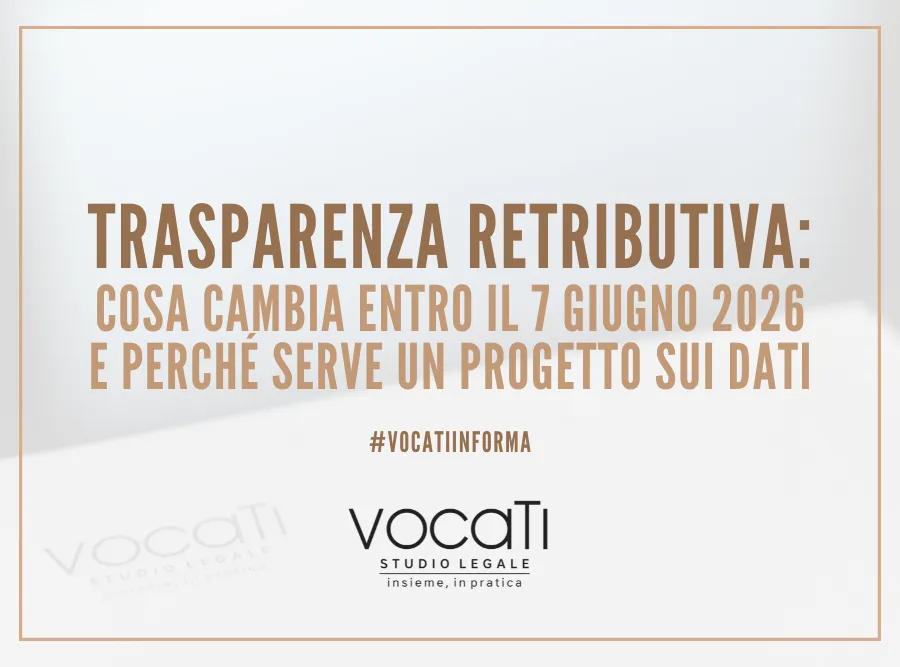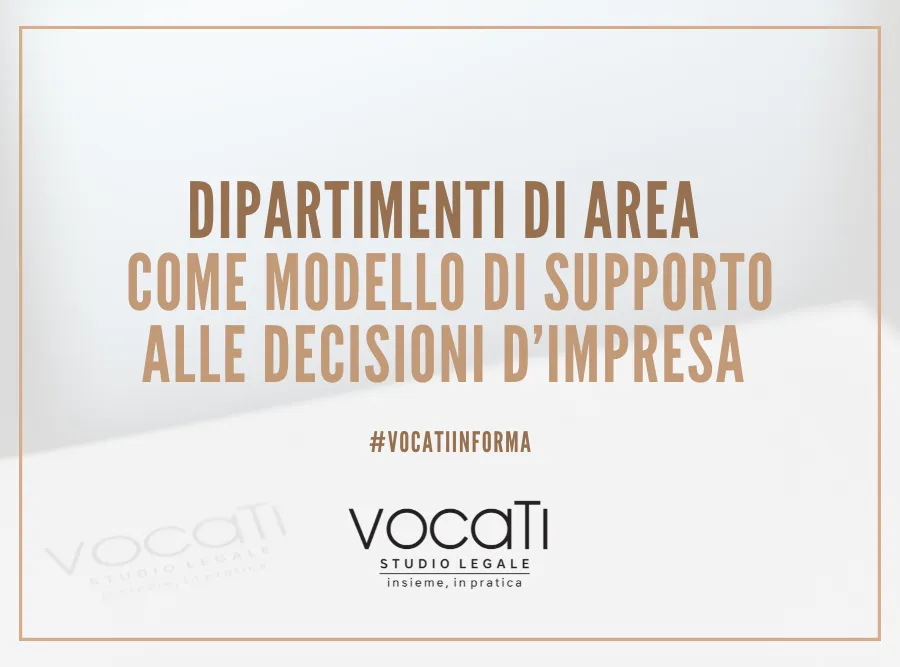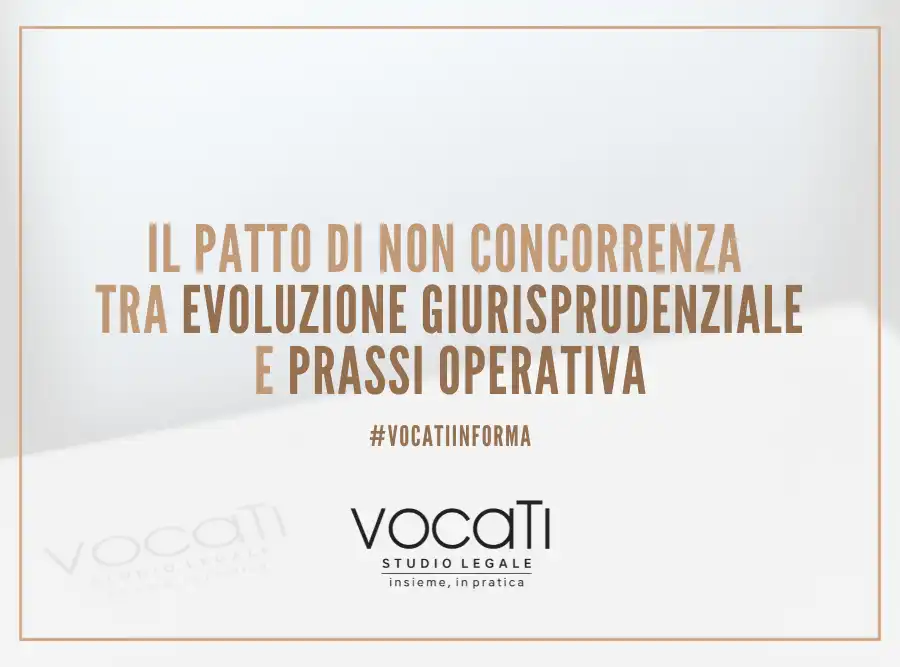
Il patto di non concorrenza rappresenta uno degli istituti più delicati del diritto del lavoro italiano, chiamato a bilanciare le legittime esigenze di tutela dell’impresa con la fondamentale libertà lavorativa del dipendente. L’evoluzione giurisprudenziale del 2025 ha consolidato un approccio sempre più rigoroso della Cassazione nel controllo di validità di tali clausole, delineando un quadro normativo particolarmente attento alla protezione del lavoratore attraverso l’imposizione di requisiti stringenti di determinatezza, congruità e proporzionalità.
La disciplina trova il suo fondamento nell’art. 2125 del codice civile, che subordina la validità di tali accordi al rispetto di tre elementi essenziali: la forma scritta, l’obbligo di un corrispettivo congruo e limiti determinati di oggetto, tempo e luogo. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato alcuni principi fondamentali attraverso le recenti decisioni della Suprema Corte, che hanno ribadito con particolare fermezza l’esigenza di determinatezza dei limiti territoriali.
L’ordinanza n. 13050 del 16 maggio 2025 ha chiarito che i limiti territoriali devono essere determinati o quantomeno determinabili ex ante, al momento della stipulazione, non potendo essere rimessi a future decisioni unilaterali del datore di lavoro. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la clausola prevedeva che il lavoratore si impegnasse a non esercitare attività in concorrenza nell’ambito territoriale nel quale, nel corso dell’ultimo anno di servizio, avesse svolto attività per conto della banca, includendo inoltre ogni nuova area di assegnazione e le province limitrofe entro un raggio di 250 km. Tale definizione territoriale è stata ritenuta eccessivamente generica e soprattutto condizionata da eventi futuri incerti, con conseguente nullità dell’impegno. La ratio della disposizione riposa sull’esigenza che il lavoratore abbia sicura contezza, fin dall’assunzione dell’impegno, dell’area geografica in relazione alla quale si esplicherà il vincolo per assumere le determinazioni più opportune sulle proprie scelte lavorative, le quali verrebbero ostacolate ove essa fosse soggetta alle determinazioni unilaterali della controparte.
La questione dei limiti chilometrici assume particolare rilevanza pratica nella redazione dei patti. L’ordinanza n. 11765 del 5 maggio 2025 ha confermato la nullità di un patto che prevedeva l’estensione del vincolo alle province limitrofe entro un raggio di 250 km dalla sede di lavoro, specificando che il datore di lavoro non può riservarsi la facoltà di modificare discrezionalmente e unilateralmente l’area territoriale interessata dal divieto attraverso l’esercizio dello ius variandi relativo al trasferimento del lavoratore. La giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui la determinabilità dell’ambito territoriale deve emergere direttamente dal testo contrattuale o da rinvii espressi a elementi oggettivi, non essendo ammissibili riferimenti aleatori o eventuali basati su future decisioni unilaterali del datore o su dati aziendali non accessibili al lavoratore. Pertanto, clausole che prevedano estensioni territoriali variabili in funzione di trasferimenti futuri o che rimettano alla discrezionalità datoriale la definizione dell’area geografica interessata dal vincolo risultano sistematicamente invalidate dalla giurisprudenza.
Un aspetto fondamentale emerso dalla recentissima giurisprudenza riguarda l’autonomia causale del patto di non concorrenza rispetto al contratto di lavoro. L’ordinanza n. 9256 dell’8 aprile 2025 ha ribadito che il patto costituisce una fattispecie negoziale autonoma e distinta dal contratto di lavoro subordinato, dotata di causa propria e configurante un contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive. Tale autonomia causale comporta che il rapporto di lavoro si riduce a mera occasione di stipula del patto, destinato a regolare i rapporti tra le parti dal momento successivo alla cessazione del rapporto lavorativo. Questa autonomia ha riflessi significativi sulla valutazione del corrispettivo, che deve essere considerato come compenso per l’autonoma obbligazione di non facere, indipendentemente dalle modalità di erogazione.
La questione della congruità del corrispettivo ha ricevuto particolare attenzione dalla recente giurisprudenza. L’ordinanza n. 9258 dell’8 aprile 2025 ha operato una distinzione fondamentale tra due profili giuridici nella valutazione del corrispettivo: il primo attiene alla determinatezza o determinabilità del corrispettivo quale elemento essenziale dell’oggetto della prestazione ai sensi dell’art. 1346 c.c., mentre il secondo concerne la congruità del corrispettivo stesso, che deve essere valutata per verificare che non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo. L’ordinanza n. 11765 del 5 maggio 2025 ha stabilito che il patto è nullo quando presenta una sproporzione manifesta tra il corrispettivo pattuito e il sacrificio imposto al lavoratore, specificando che la validità richiede un compenso non meramente simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto e alla riduzione delle capacità di guadagno. La giurisprudenza ha ritenuto in più occasioni irrisorio un compenso inferiore al 15-20% della RAL annuale, richiedendo una proporzionalità effettiva rispetto alla limitazione imposta.
Tutto quanto sopra deve essere letto anche con riferimento alle diverse conseguenze fiscali e previdenziali in base al momento di erogazione del corrispettivo, aspetto di particolare rilevanza pratica per la gestione operativa.
Quando il corrispettivo viene erogato mensilmente in costanza di rapporto di lavoro, esso costituisce retribuzione imponibile sia dal punto di vista fiscale che previdenziale secondo gli ordinari criteri, con incidenza sulla retribuzione indiretta e differita del lavoratore, incluso il calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. Diversamente, l’erogazione dal momento della cessazione del rapporto di lavoro in avanti comporta che sull’importo sia dovuta la contribuzione previdenziale INPS, l’assoggettamento a tassazione separata per il lavoratore senza alcuna incidenza a titolo di retribuzione indiretta, differita e di TFR. Particolarmente interessante è l’ipotesi in cui il patto venga sottoscritto dopo la cessazione del rapporto di lavoro, caso in cui non sarà dovuta alcuna contribuzione previdenziale, mentre per quanto riguarda l’aspetto fiscale, gli importi erogati saranno ricondotti tra i redditi diversi con assoggettamento a ritenuta d’acconto del 20%.
L’evoluzione giurisprudenziale del 2025 conferma la centralità del bilanciamento tra le legittime esigenze di tutela dell’impresa e la fondamentale libertà lavorativa del dipendente, richiedendo agli operatori del settore un approccio sempre più attento e specialistico nella gestione di questi delicati strumenti contrattuali. Le recenti pronunce della Suprema Corte offrono un quadro di riferimento chiaro per la redazione di patti validi ed efficaci, sottolineando l’importanza di garantire al lavoratore piena consapevolezza delle limitazioni assunte e delle conseguenze economiche del vincolo, evitando formule generiche o dilatabili che potrebbero compromettere la validità dell’intero accordo.