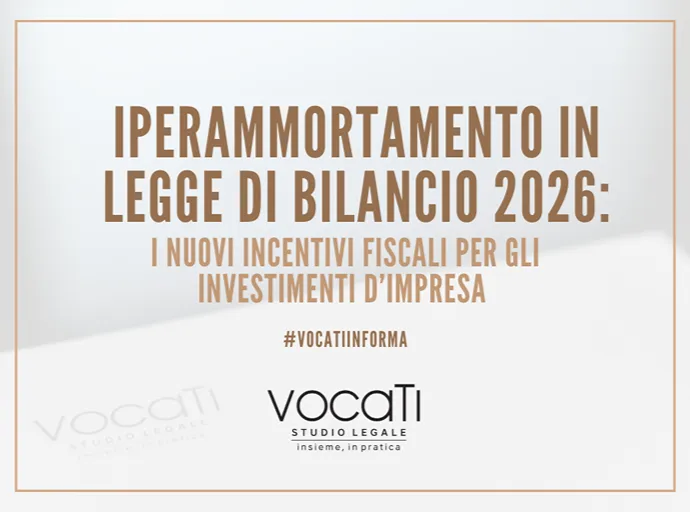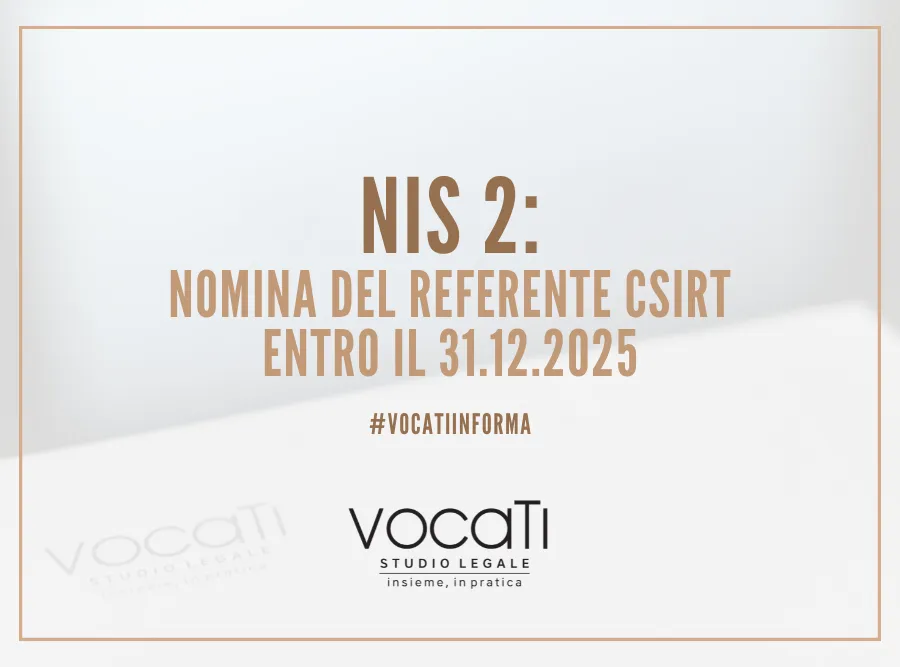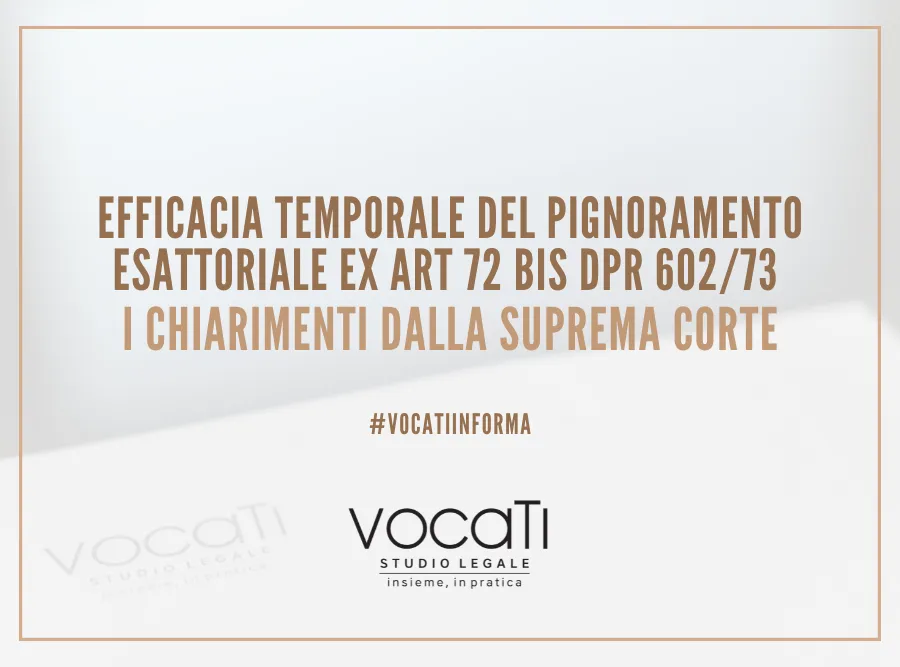intelligenza artificiale e lavoro
Con l’approvazione della legge n. 132 del 2025, il legislatore italiano ha introdotto un quadro normativo organico per disciplinare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, stabilendo principi e obblighi vincolanti per chi intende avvalersi di queste tecnologie nella gestione del personale.
La nuova disciplina, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, si inserisce nel solco tracciato dal Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024 e mira a promuovere un impiego corretto, trasparente e responsabile dell’AI, secondo una visione antropocentrica che sappia cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica garantendo al contempo la vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali delle persone.
L’intelligenza artificiale al servizio della gestione delle risorse umane
La riflessione odierna si concentra sull’applicazione dell’intelligenza artificiale alla gestione del personale, ambito nel quale la nuova normativa impone ai datori di lavoro e ai committenti una serie di adempimenti rigorosi, ben delineati dall’articolo 11 della legge n. 132/2025. Questa disposizione, articolata in tre commi, si riallaccia alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 104/2022 nel D.Lgs. n. 152/1997, imponendo una serie di obblighi stringenti a tutela dei lavoratori.
Prevenzione delle discriminazioni e salvaguardia della dignità umana
Un principio cardine della nuova disciplina è l’assoluta necessità di impedire che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generi comportamenti discriminatori, sin dalla fase di selezione del personale o di conferimento degli incarichi. Tale esigenza trova del resto solido fondamento nell’articolo 3 della Costituzione, nell’articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori, nel D.Lgs. n. 198/2006 e nel D.Lgs. n. 215/2003, per citare soltanto le disposizioni più rilevanti del nostro ordinamento in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazione.
Gli obiettivi dell’impiego dell’AI nelle relazioni di lavoro
Procedendo con ordine, occorre sottolineare come la stessa rubrica dell’articolo parli espressamente di “Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro“, evidenziando la portata generale della disciplina.
Il primo comma stabilisce con chiarezza che l’impiego dell’intelligenza artificiale deve essere finalizzato a:
- Migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti;
- Tutelare l’integrità psicofisica delle persone che lavorano;
- Elevare la qualità delle prestazioni professionali;
- Incrementare la produttività individuale, sempre nel rispetto del diritto dell’Unione Europea;
- Gli obblighi di informazione e trasparenza verso i lavoratori.
Il secondo (e fondamente) comma dell’articolo 11 contiene le disposizioni più rilevanti dal punto di vista operativo, ponendo l’accento su affidabilità, trasparenza, inviolabilità dei dati personali riservati e rispetto della dignità umana. Il datore di lavoro e il committente – e qui va sottolineato che l’obbligo si estende anche ai rapporti di collaborazione comunque denominati – sono tenuti a informare il lavoratore nei casi previsti dall’articolo 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2022.
I casi richiamati riguardano specificamente l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio completamente automatizzati.
Fatte salve le procedure previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori in materia di controlli a distanza – che seguono iter ben codificati dalla norma e dalla prassi amministrativa – il datore di lavoro e il committente, sia pubblico che privato, devono informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio totalmente automatizzati destinati a fornire indicazioni rilevanti per:
- L’assunzione del personale;
- Il conferimento di incarichi professionali;
- La gestione del rapporto di lavoro e la sua eventuale cessazione;
- L’assegnazione di compiti e mansioni specifiche;
- Le indicazioni relative alla sorveglianza, alla valutazione delle prestazioni e all’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- Il contenuto essenziale dell’informativa da fornire al lavoratore.
Ma come si adempie concretamente a tali obblighi informativi?
La risposta è fornita dal comma 2 dell’articolo 1-bis, che stabilisce come, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, oltre alle informazioni obbligatorie già previste dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 152/1997 – in vigore da ventotto anni – qualora si utilizzino sistemi integralmente automatizzati, occorra specificare:
Gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’intelligenza artificiale, gli scopi e le finalità, perseguite attraverso i sistemi automatizzati, la logica di funzionamento di tali sistemi, le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, compresi i meccanismi di valutazione, le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il nominativo del responsabile del sistema di gestione della qualità, il livello di accuratezza, robustezza e cyber sicurezza dei sistemi, le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse, i diritti di accesso alle informazioni e i tempi di risposta.
Il successivo comma 3 riconosce al lavoratore, direttamente o tramite le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali, il diritto di accedere ai dati o di richiedere ulteriori informazioni relative a quanto comunicato. Il datore di lavoro o il committente hanno l’obbligo di rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla richiesta. Su questi ultimi grava, inoltre, ai sensi del comma 4, l’obbligo di fornire una nuova informativa scritta almeno ventiquattro ore prima, qualora intervengano variazioni rispetto alla precedente comunicazione che incidano sulle condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro (comma 5).
La comunicazione alle rappresentanze sindacali
Le informazioni e i dati comunicati al lavoratore o al collaboratore, strutturati in forma leggibile e trasparente, devono essere comunicati anche alla rappresentanza sindacale unitaria, se presente in azienda, o, in mancanza, alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 6). Sia il Ministero del Lavoro che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso le proprie articolazioni territoriali, possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e accedere ai dati.
Le conseguenze in caso di inadempimento e il sistema sanzionatorio
Ma cosa accade se il datore di lavoro o il committente – per il quale sussiste uno specifico riferimento ai rapporti di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile e all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 – non ottemperano agli obblighi previsti?
Trova applicazione l’articolo 4 del D.Lgs. n. 152/1997 che, in caso di mancato, ritardato, incompleto o inesatto adempimento degli obblighi, rinvia per la quantificazione delle sanzioni amministrative, una volta esauriti gli accertamenti, all’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Tale disposizione prevede, per la violazione dell’articolo 1-bis, commi 2, 3 secondo periodo e 5, una sanzione pecuniaria da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento, ferma restando la configurabilità di eventuali sanzioni in materia di protezione dei dati personali qualora ne sussistano i presupposti ai sensi dell’articolo 83 del Regolamento UE 2016/679. Nel caso di mancata comunicazione alle strutture sindacali, la sanzione amministrativa è compresa tra 400 e 1.500 euro per ciascun mese nel quale si verifica la violazione.